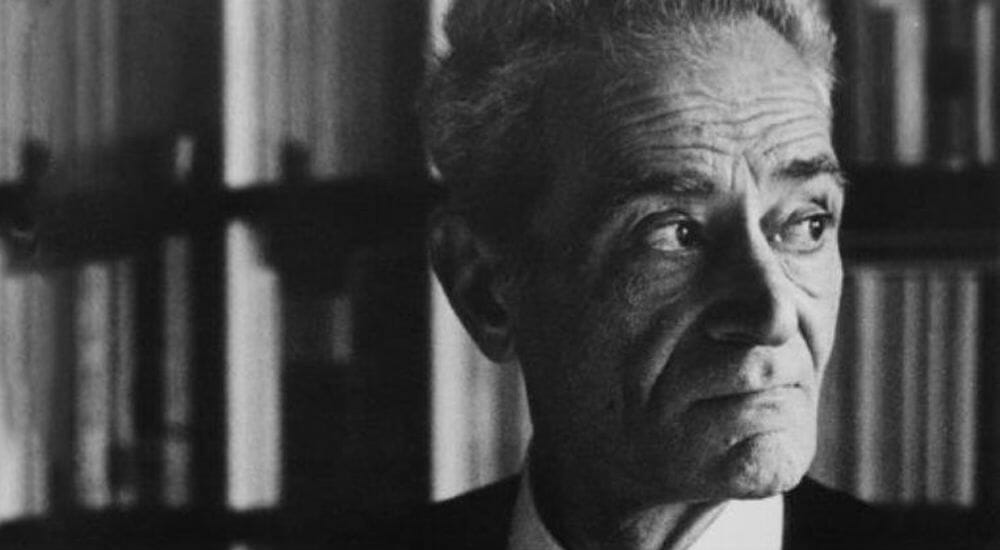Il volume Caproni. Tutte le poesie (Garzanti) raccoglie l’intera produzione di Giorgio Caproni, compresa Res Amissa, pubblicato postumo nel 1991. È dunque possibile cogliere nella sua interezza una delle più importanti voci poetiche del Novecento. Il dato essenziale della modernità di Giorgio Caproni è quella sua particolare musica cui si deve la naturalezza con cui il poeta passa, senza mutar tono, dal quotidiano all’astratto, dal colore al disegno, dal colloquiale all’epigrafico, dal domestico al metafisico. Temi preferiti da Caproni sono il viaggio, la frontiera, le terre di nessuno con i loro paesaggi solitari e le loro rare apparizioni e la caccia, ossessiva, a un’imprendibile preda. Unico rifugio umano è proprio l’incerto confine tra il vero e l’immaginario, tra il certo e il possibile: anche l’assoluto, se esiste, abita nell’ambiguità.
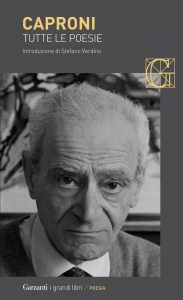
Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it pubblichiamo un estratto dal volume:
L’INTRODUZIONE di Stefano Verdino
1. L’arco della poesia di Giorgio Caproni si estende per quasi sessant’anni, dai primi anni Trenta alla fine degli anni Ottanta del Novecento, da un mondo (e un’Italia) di pennini e calamai e di ben rari telefoni all’avvio della rivoluzione informatica globale: un percorso quindi di molte epoche e modi di vita e di molti io nella vita di un uomo, declinati in quei tempi diversi, quegli io «cari e odiosi» della poesia Oh cari, scritta quando per la prima volta Caproni si trovò a fronte del corpus di tutti i suoi versi edito da Garzanti (1983).
Certo se prendiamo la prima e l’ultima poesia di questo insieme le differenze sono molte, a partire da quelle tra la posizione nitidamente definita dell’inizio – l’apertura di Marzo – e la posizione dei tre «versicoli» di Anch’io, parte di un libro postumo come Res amissa, e quindi per sua natura ipotetico. Due poesie, comunque, che meglio non potrebbero definire apertura e chiusura: da un lato l’avvento di un «sole bianco» sorridente e il gesto di «una fanciulla che apre la finestra», dall’altro un “autoritratto” come «albero fulminato» in una vasta schiera di simili, insomma un cimitero di legni bruciati «dalla fuga di Dio», si specifica; tragitto quindi da una presenza umana e amorosa, in lessico volutamente classico («la fanciulla»), a una devastante distruzione fisica che rimanda a un’assenza metafisica. Tante cose vi stanno in mezzo, è ovvio, ma non posso non rilevare una fedeltà primaria, alla rima, innanzitutto, e poi a una peculiare marcatura metaforica: la rima chiara e frontale («sbucciato-bagnato»; «io-Dio»), la sinestesia giovanile («il fiato del fieno bagnato») e il paradosso terminale («fulminato dalla fuga di Dio»), modi diversi, ma uniti dalla nettezza, come dire, “intagliata” delle parole.
2. Tutto questo ci dice di un operare rigoroso sul linguaggio, da «poeta minatore», come Caproni amava definirsi, che nelle buie gallerie dell’anima (espressione carpita a Machado) estrae «nodi di luce», ma anche ci dice di un grande poeta capace di molte gamme, lavorando con pochi e costanti strumenti. E qui entra in gioco una seconda strategia, «l’economia delle parole», il fastidio per la verbosità spesso connessa alla pratica poetica italiana, l’attenzione all’essenzialità del dettato, imparata in gioventù – a suo dire – dall’Allegria di Ungaretti, ma declinata con tutt’altro spirito: non la “parola pura”, ma la “parola netta”, verrebbe da dire, quella capace di scandirsi con il minor tasso letterario possibile, «fine e popolare», ovvero «verde» ed «elementare» come sono i requisiti imposti alla sua strategia di rime limpide e squillanti. E infine, terzo ingrediente, la levità, quel tocco di grazia e leggerezza che quasi sempre contraddistingue la sua poesia, capace come poche di dire il dolore e la disperazione (per la perdita di ciò che è vivente, per la solitudine, per la «frana della ragione»), ma di dirli in termini anche contrastivi, in «straziata allegria», dove allegria va intesa principalmente in significato musicale, come un tempo veloce e rapido in cui iscrivere il testo.
Sono scelte e ingredienti decisamente originali nel quadro della poesia italiana del Novecento, che pongono Caproni in modo eccentrico rispetto alle linee di sviluppo coeve: tra i meno sensibili alla fascinazione dannunziana (praticata da Montale a Luzi), preferì da giovane ritagliare un proprio Carducci, «macchiaiolo» diceva, di fragranti impressioni, corretto però da qualche tonalità più antica del ritmo (tra Poliziano e il Tasso lirico) e una propensione un poco surreale dell’immagine, attinta da coevi esempi spagnoli e dal primo Gatto.
3. Fin da subito è chiara la partita che intende giocare questa poesia, quella che in anni più tardi si figurerà come una «caccia» (dal Guardacaccia del Congedo del viaggiatore cerimonioso in poi); ed è la difficoltà della parola a esprimere, a “catturare” i fragili e fuggenti aspetti della vita. Diversamente da quasi tutti i poeti della sua e della precedente generazione, Caproni, fin da giovane, nei tempi della poesia pura e dell’Ermetismo, non ha mai avuto fiducia nella “forza” del linguaggio; ha subito visto uno iato tra parole e cose, quanto più problematico in una poesia come la sua che vuole essere precisa e puntuale, aderente ad aspetti concreti. Tutto è già ben chiaro dal luminoso e sensoriale poeta di Come un’allegoria (1936). In questa breve silloge di 17 poesie leggiamo Borgoratti, allora sobborgo popolare di Genova: siamo in una «sera» di «labile memoria» delle «vampe fiorite / ai balconi di questo paese»; c’è quindi un senso di fragilità evidente nel fermare l’immagine o il ricordo, ma nella seconda strofe l’apparizione di una «fanciulla» «sulla porta dell’osteria» si staglia nitida «come un’allegoria», vale a dire come una precisa figurazione, che però è altra cosa dalla fuggitiva e imprendibile realtà. Caproni si commentava: «Noi possiamo avere, al massimo, l’allegoria di questa realtà» e «la letteratura crea una seconda realtà, che nasconde la prima, quindi Come un’allegoria». Non a caso tante volte ci troviamo, nei suoi versi, di fronte all’«uomo solo» nel «chiuso della sua stanza» o allo «scrittoio», che «inventa l’erba / facile delle parole».
In poco tempo dall’esordio del poeta della «labile memoria» e poi della vita «precaria» si passa con Gli anni tedeschi (in Il passaggio d’Enea) – nel cuore della seconda guerra – al drammatico divario tra i nomi e la realtà («Ahi i nomi per l’eterno abbandonati / sui sassi»), quei nomi che sono la sola identità umana, ma dispersa e impotente davanti alla devastazione della storia, nel caso la guerra, per cui mancano adeguati e possibili raffigurazioni nel linguaggio. Il nominalismo caproniano non farà che aggravarsi successivamente, ma invece di dare adito al silenzio o all’afasia, si intestardirà nella sua caccia prima al reale, poi al metareale e al metafisico (Dio, la Bestia come allegoria del male e di altro), con mille rifrazioni e speculari reversibilità, tra Dio e l’io, tra la bestia e la parola, in una persistente e mobile destrutturazione di tutti i parametri conoscitivi, a partire dal principio di identità. Ne è scaturita una poesia di conoscenza e di invenzione, in cui l’aporia in cui naufragano i vari moti di pensiero dell’autore viene rilanciata in dinamiche di paradosso e racconto, trapunte da perentori aforismi, in virtù di quella spinta originaria all’allegoria, come gioco di figurazione sul bilico di un abisso di conoscenza e un fortissimo di concertazione espressiva, grazie al sempre più ricco menù di ingredienti (rime, metafore, personaggi, scene ecc.).
Primaria è l’allegoria del viaggio, che s’avvia con Il passaggio d’Enea, tra biciclette, mezzi di trasporto urbani e proiezione nel mito (Enea), e rimarrà un cardine con tante gamme (dai viaggi nuziali, funebri e inferi di Annina nel Seme del piangere, al Viaggiatore cerimonioso ai movimenti partigiani e agli esodi del Muro della terra e oltre). Connessa vi è quella di Genova, «città di tutta la vita», esaltata nei suoi specifici aspetti e nei suoi termini toponomastici, non a caso, dal Caproni “romano”, quando cioè Genova è «perduta» ed è un alimento che dalla memoria fluisce nell’invenzione e nella scena del testo, mentre dal Muro in poi vi sarà preferita l’alta val Trebbia, del paese natio della moglie Rina, i cui termini concreti (lo spopolamento, la traccia partigiana, l’ambiente boschivo e freddo) costituiscono peculiari ingredienti per l’ultima spettrale stagione. Infine la figura umana che da oggetto o interlocutrice si emancipa, negli anni Cinquanta, in una gamma di personaggi i quali acquistano sempre più spicco, mentre l’io del poeta si va riducendo a maschera di scena, in reversibile scambio con le figure dell’alterità.
4. Proprio il nominalismo fa sì che Caproni, fin da subito lavori per sfruttare al massimo – in quel quadro di economia espressiva – le sue risorse, all’interno di una dinamica di “tema e variazioni”, per cui una scelta volutamente limitata di temi produce una serie di sviluppi, grazie alla strategia della variazione (molto cara alla letteratura violinistica, ben presente a lui suonatore di violino). Ritorniamo un momento a Borgoratti e a quei versi citati: eccoci davanti a un toponimo, primo di una assai vasta gamma di nomi propri di luogo e poi di persona, sigillo di un massimo di individuazione possibile (nella caccia al reale); e poi ecco la «fanciulla», variata altrove in «donne» e «ragazze» che si susseguono in un continuo passaggio (leggiadro e sfuggente) lungo tutta la sua vicenda poetica; quindi «l’osteria», altro caposaldo locativo (con le varianti di «bar», «locanda», «locale») per una scena costante e variata, tra locali affollati, fumosi o solitari e desolati come un «erebo» con quel fraterno vino carducciano, spesso presente come confortante «bicchiere». Anche la «porta», infine, ha la sua lunga storia, in Borgoratti è cornice di festosa apparizione, altrove sarà di inquietante soglia di un dove ignoto (Alba, Ad portam inferi), quando non «tomba» di chiusura funeraria. Spesso Caproni si appunta su dati di comune esperienza umana – i pubblici locali e mezzi di trasporto, per esempio – per un bisogno di concretezza quotidiana, come punto d’avvio della sua trasfigurazione poetica («una poesia dove non si nota nemmeno un bicchiere o una stringa, m’ha sempre messo in sospetto», diceva).
Come ogni grande poeta, Caproni elabora un lessico suo proprio, ma più di altri – per il suo nominalismo – ha bisogno di farlo risuonare, ripetere e variare, per sentirselo da un lato proprio e dall’altro per elaborarne un insieme di figurazione allegorica. Ci sono – a questo proposito – due coppie di parole (molto spesso in ripetuta rima) da cui partire: «terra-guerra», «passo-sasso» (o «passi-sassi»), che potremo prendere a emblema. La prima coppia («terra-guerra») ci rimanda all’evidente esperienza biografica della ferita della guerra, come si vede nella dolente poesia di separazione coniugale dalla moglie Rina (Così lontano l’azzurro): «Tu persa in quella terra / di pietra, io solo in questa / silenziosa mia guerra». Ma con il tempo la guerra diverrà una figurazione allegorica (con mutevoli connotati tra moderni e antichi), quasi un destino “baciato” in rima con terra, atto a plurisensi, dall’oltraggio bellico reale («Com’era già in lei, e in terra / il seme della guerra») alle “cacce” metafisiche: «È stata tutta una guerra / d’unghie. Ma ora so. Nessuno / potrà mai perforare / il muro della terra». La seconda coppia invece («passo»: «sasso») riguarda un dato più esistenziale, e cioè la fragilità del vitale passaggio umano opposto alla immobilità durevole del «sasso» (a volte anche di connotato sepolcrale); così in Lamenti III (al padre) al «mio tranquillo passo» del passato risponde «ora cade / come un sasso tuo figlio», mentre in Aspettando Silvana (da Res amissa) prende spicco un’attesa più astratta ed enigmatica, un po’ beckettiana: «Senza / che io ne abbia scorto o udito / (Quasi fossi di sasso) / la figura: il passo».
Con vari lemmi-chiave possiamo percorrere verticalmente l’opera poetica di Caproni quali segnali di variazioni sul tema, ma anche di possibili cesure: per esempio le gamme della sonorità si danno sempre un fecondo cambio nella sua poesia, dall’esibizione degli strumenti musicali ai «gridi», agli «schianti» (spesso, dal Muro della terra in poi, come armi da fuoco connesse alla caccia), al vibrare del «vento», grande protagonista con la sua emblematica di assoluta mobilità, sradicante tempo e spazio; l’altra sensorialità, tra gusto e olfatto, che tanto lo intriga all’origine per trasmettere la fragranza del vivente, con abbondanza di sudori e odori, verrà a cessare nell’ultima stagione che si apre con Il muro della terra, quando Caproni opta per una decisa concentrazione e riduzione di campo. Anche la luce trapassa dal «chiareggiato mattino» dei primi anni alla «luce nera» ossimorica di L’ascensore, successivamente spesso ripresa e variata («buia lanterna», «buio ardente») in una poesia che si va caricando di «tenebre» e «nebbia» (da Le stanze della funicolare in poi) o di luce filtrante nel buio (Il passaggio d’Enea); alla fine non resta che una «lamina», con conseguente spegnimento dei colori giovanili, dal bianco al rosso (specie in Cronistoria), per il «piombo» o l’«acciaio», semanticamente anche contigui al linguaggio d’armi di guerra e caccia. Ma è anche possibile la «lampadina» «accesa nel sole / sopra il deserto», una luminosità assurda e disabitata, di opposta e diversa figurazione, ma analoga nel suggerire gli effetti di una disabitazione dell’umano.
5. Ma è tempo di fare un po’ di storia di questa poesia, rimarcando ora le varie stazioni con i loro cambi di passo. L’insieme di Come un’allegoria (1936), Ballo a Fontanigorda (1938) e Finzioni (1941) ci consegna agili plaquette compatte nel loro dettato di liriche per lo più idilliche ma decisamente «precarie» (e con tratti di malinconia), come si è detto: sono brevi quadri di ricca sensorialità su scenari marini, campestri o di periferia, dove spesso è messa a fuoco l’interlocutrice femminile, di cui si cerca di fermare un tratto; nei primi due libretti vi è un ritmo costante, tra apertura (nelle rispettive prime liriche) e chiusura (i testi finali di Dietro i vetri e il tombeau per Olga, la prima fidanzata). In Finzioni all’apertura marina e femminile si contrappone, quasi alla fine della serie, la foto di gruppo di Giro del Fullo, serale e montano, dove appare il primo «tram» di un benemerito dei mezzi di trasporto pubblici come Caproni, ma il libretto si chiude con la sperimentazione dei primi sonetti “monoblocco” (cioè senza scansione di quartine e terzine), che inaugura una forma ripresa in Cronistoria (1943) e negli Anni tedeschi del Passaggio d’Enea. Non è forse un caso che siamo negli anni di guerra, anni ardui, come ardua è qui la partita tra la forma chiusa e l’arco o respiro della frase che – dopo le primizie alla Folgòre di Finzioni – si scandisce in lutto privato (Sonetti dell’anniversario, sulla perduta Olga) o lutto comune, nel «disastro» del tempo più cupo di guerra, il 1944 (I lamenti). Rilevante è la modalità seriale dei due cicli di sonetti, come primo avviso di emancipazione da una misura lirica per una reclamata dinamica intertestuale, che rilanci e leghi il dettato nell’osmosi della serie; separato, a mo’ di premessa, si legge l’autoritratto di Alba, indirizzato all’«amore mio»: qui si inaugura il registro invernale della sua poesia (che avrà un significativo riverbero allegorico dal Muro della terra) con connessi brividi e tremitii; l’esito è mirabile perché vi è una sottile intenzionalità esistenziale dei connotatori fisici, mentre la dubbiosa attesa della figura femminile produce uno sgomento intercambiabile tra vita e morte.
Segue la stagione dei poemetti orchestrati in stanze di 16 versi (un simulacro di doppia ottava sull’eco di Poliziano) che completano Il passaggio d’Enea (1956). Sono scritti in anni in cui Caproni si misura variamente con la prosa e il racconto su giornali e riviste e prova anche in versi la sua “vocazione” narrativa o per lo meno discorsiva. Allora Caproni come altri poeti della sua generazione tendeva a emanciparsi dal vincolo lirico della poesia novecentesca: nell’immediato dopoguerra la sua via principale è quella del poemetto in stanze (Le biciclette, Stanze della funicolare, All Alone, Il passaggio d’Enea). Se le Biciclette, sorta di memoriale in versi, manifesta l’irreparabile perdita della propria vita («né ora più / v’è soccorso a quel tempo ormai diviso», avvisa il refrain), la Funicolare generalizza il quadro con l’allegoria di un immaginario percorso di una funicolare genovese: un viaggio in cui «l’utente» non riesce mai a «chiedere l’alt», finché questo metropolitano bateau ivre approda a una «nebbia» che moltiplicandosi cancella ogni discorso. All alone è nei Versi il poemetto più eliotiano sugli «uomini miti» (e non vuoti) che «battono vanamente altra speranza», mentre Didascalia ed Epilogo si pongono dal punto di vista dell’io, rievocando una Genova vicolare tra chiuso e aperto. Chiude la serie il poemetto eponimo con la proiezione in un «tuo Enea» «che in spalla / un passato che crolla tenta invano / di porre in salvo» (il vecchio padre Anchise) e «per la mano ha ancora così gracile un futuro / da non reggersi ritto» (il figlio).
6. Una via secondaria, apparentemente più leggera e cantabile, è la via dell’Ascensore e dei versi Su cartolina. Se noi guardiamo alla successiva opera di Caproni, non è difficile intendere che tale via secondaria – in Appendice a Il passaggio d’Enea – è stata invece la strada maestra, da cui è disceso Il seme del piangere (1959), ma anche in buona sostanza tutto il resto della propria opera, dove la rima chiara è largamente preponderante e dove lo stesso andamento narrativo e non lirico appare derivato dall’originale e stranita canzonetta dell’Ascensore e non dall’allegorismo più evidente dei suoi poemetti.
L’Ascensore, scritto nel 1948, per tutelarsi dall’ingorgo sentimentale e dal patetico imbocca una sperimentazione di tipo verdiano («torniamo all’antico e sarà un progresso»): l’antico di Caproni è la forma della canzonetta in settenari, potenziando la sua funzione di spiazzamento musicale e curvando con decisione il “pianto” nel “canto” (tanto per rimanere fedeli al gioco di rima). All’origine c’è – indubitabile – una situazione biografica: la madre “condannata” dalla malattia e il proprio disagio di figlio lontano. E qui invece il colpo di genio, l’opzione di straniamento, ovvero di profonda correzione del dato biografico originario, quasi un contropiede: l’angosciato figlio – con evidenti complessi di colpa del “salvato” per chi sta per essere “sommerso” – imbastisce questi versi in cui il patetico è corretto dal paradosso e dal sogno o «leggenda» per usare il suo linguaggio, inventando il personaggio della madre giovane a modo di risarcimento, come sarà per tutto il Seme del piangere. E ribadisco la parola invenzione, giacché qui e nel Seme Caproni inventa la propria madre, rievocandola in un fuori tempo e precisando il suo amore non per la madre, ma per Annina.
Il Seme del piangere si configura come canzoniere di morte e di vita per Annina, sovrapponendo il lutto per la sua scomparsa all’allegria dei diversi fotogrammi della ragazza in bicicletta nella Livorno di primo Novecento, con una concertazione intertestuale tra le poesie decisamente allora inedita nella poesia italiana: Ad portam inferi configura la primizia della spaesante scena di bar e stazione con «tanto fumo» in cui il personaggio di Annina, in attesa dell’«ultima destinazione», naufraga nella confusione (di mente e di memoria), una poesia davvero di vertice per l’originalità figurale con cui ci dice tenerezza, struggimento e smarrimento per l’ineluttabile cancellarsi del vivente e per la resa della donna a un inerme preghiera («Signore cosa devo fare»); ma a questo registro grave succede Eppure che fin dal titolo ci avvisa del suo cambio di passo con il festoso trillo del giorno e viaggio nuziale, per quanto infine insidiato dalla «guerra».
Con Il seme del piangere nasce un vero e proprio “libro” di poesia, con una orchestrazione più narrativa tra i testi in un comune disegno, una formula che Caproni svilupperà nei libri successivi e che sarà anche ripresa da altri poeti come Luzi e Zanzotto. Nel Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee (1965) infatti ci troviamo a fronte delle nuove maschere di personaggi (viaggiatore, guida, guardacaccia, preticello), multipli e allegorici alter ego nei diversi monologhi delle rispettive prosopopee, mentre l’io declina in proprio alcune canzonette sui propri ricordi, trasformati in spiazzanti situazioni sceniche di mancata comunicazione, con esiti certo molto distanti dalla poesia della memoria praticata nel nostro Novecento.
Accanto a nuove figurazioni di Livorno e Genova si rimodellano allegoricamente gli amati treni e le osterie, ora connessi a un oltre (la discesa, il bosco) allarmante, mentre come «conquista» può darsi un «prato» di sosta o una paradossale preghiera – nella voce del preticello – «come uso soffrire / io, perché Dio esista».
7. Dieci anni separano Il congedo da Il muro della terra (1975), il più lungo intervallo tra i suoi libri. E vi è una ragione: per quanto la continuità compositiva dei singoli testi sia attestata dalle date, il nuovo libro tardò a configurarsi, finché non si delineò un nuovo e decisivo scarto nella sua opera poetica, poi sviluppato con Il franco cacciatore (1982), Il conte di Kevenhüller (1987) e Res amissa (1991): una serie di motivi come l’allegoresi montana e borghigiana, i temi del viaggio, della caccia e di Dio s’innestano in una profonda revisione stilistica, in cui sono chiamati anche elementi non verbali. Merita conto citare una dichiarazione d’autore: «Il rumore delle parole, della loro sovrabbondanza, mi ha stancato presto. Ho provato con l’orchestra sinfonica, ma poi ho preferito la musica da camera». Rispetto alla poematicità del Passaggio d’Enea, ma per certi versi anche delle prosopopee, l’ultimo Caproni stringe sul suo principio d’economia: riduce la sua sintassi, abbrevia drasticamente la frase, a volte ridotta solo a una parola, mentre proliferano trattini, parentesi, puntini, interrogative, antiche interpunzioni in uso dalle sue origini, ma qui risignificate nello spicco a bloccare il flusso verbale, quasi pietrificandolo e pausandolo; l’effetto scandito di parole e grafemi si riverbera poi con il fitto uso di versi a scalino e varie spaziature strofiche, che infittiscono gli interstizi tra le parole. Insomma il testo assomiglia a una partitura, ha un suo “tempo” di esecuzione decisamente segnato dall’autore; e se da una parte Caproni – nel suo bisogno di precisione – vuol proprio sulla pagina far vedere il vuoto (e far sentire il silenzio) che assedia il linguaggio, dall’altra parte ne incrementa la sonorità in un “fortissimo” (per così dire) della rima, qui al massimo della sua resa. Ancora: si rinforza la valenza narrativa, ma la si intervalla a testi brevi, aforistici, di fulminante battuta: «Sta forse nel suo non essere / l’immensità di Dio?» (Pensiero pio). I libri infine si scandiscono in una serie di partizioni connesse dove rilevanti sono anche le parti “secondarie”, cioè i paratesti, le didascalie, le dediche con vari giochi di falsetto, in una ironica mimesi della librettistica d’opera (specie Il Franco cacciatore e Il conte), che in realtà costituisce uno dei più profondi e originali ripensamenti della forma poetica dell’occidente europeo.
La forma è così piena realizzazione dell’interrogazione sui fondamenti della vita e del suo oltre che rendiconta un «vuoto» inespungibile, ma il reiterato scacco conoscitivo non declina in afasia o rinuncia, ma si rilancia sempre in possibilità allegorica di arcatura narrativa variata nei volumi: nel Muro della terra è il viaggio sempre spiazzato dai suoi esiti, nel Franco cacciatore la caccia a Dio e all’io, reversibili quanto irreperibili identità, nel Conte la caccia alla bestia inafferrabile, perlopiù allegoria dell’inaffidabile linguaggio. Non possiamo attestare il disegno autoriale per il postumo Res amissa, orientata sul bene perduto (o forse mai avuto), ma è chiaro che le testimonianze concorrono sempre in un maggior affinamento di costruzioni in versi di parole e grafemi e di linguaggio segnaletico (Res amissa e Statale 45).
Nel complesso gioco di contrappunti di questa sua ultima stagione il ben praticato dinamismo intertestuale configura una varietà formale dei testi che potremmo rubricare come recitativi, ariosi e arie, a seconda della diversa tessitura tra segni e rime, in un mirabile equilibrio di grave e lieve, che è sempre il maggior incanto della poesia caproniana, capace di sondare i più desolati e amari territori del vuoto, ma sempre in modi luminosi, grazie alla sua nitida resa di canto, una virtù, questa, decisamente mozartiana.
Fonte: www.illibraio.it